Ad un anno dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, la Dottoressa Letizia Traversi, medico della Pneumologia dell’Ospedale di Circolo, racconta la sua esperienza vissuta accanto ai pazienti Covid.
Varese, 20 Febbraio 2021
Ad un anno esatto dall’inizio dell’emergenza mondiale che ha cambiato le nostre vite, arriva la testimonianza di una giovane professionista, la Dottoressa Letizia Traversi, che ha prestato servizio in questi mesi nella Pneumologia dell’Ospedale di Circolo di Varese e che ora, un po’ a malincuore, lascia per andare ad inseguire il suo sogno di ricercatrice.
Sono parole che, con grande equilibrio, raccontano un’esperienza davvero estrema, fisicamente e soprattutto psicologicamente, una testimonianza che Letizia dedica ai suoi colleghi, ai tanti che, come lei, sono stati gli artefici della grande impresa compiuta da questa Azienda e purtroppo ancora in corso.
Il caso ha voluto che queste parole giungessero proprio in concomitanza con il triste anniversario che cade proprio domani.
“Oggi si conclude una fase della mia vita così strana e intensa che se me ne avessero parlato, un anno fa, non avrei saputo crederci. Da marzo 2019 la vita di tutti è stata travolta inaspettatamente, in un modo o nell’altro… il fatto che mi trovassi al termine del percorso di specializzazione in Pneumologia all’Ospedale di Varese ha complicato ulteriormente le cose! Ho cercato di parlarne il minimo tramite i social, ma ora che questa porta si chiude voglio raccontare a tutti quello che è stato. Sarà la voglia di condividere un’esperienza, sarà il bisogno di esorcizzare le sue parti peggiori, o il desiderio di rendere omaggio a chi continuerà a viverla ora che me ne sono tirata fuori, ma ho deciso di aggiungere la mia voce alle tante che parlano, non sempre a proposito.
Ci tengo a fare una fondamentale precisazione: l’unica esperienza che posso portare è quella che ho vissuto. Sembra banale, ma in ogni reparto, in ogni città, a seconda del periodo, il vissuto personale e professionale è diverso e soggettivo. A maggio, dopo una prima ondata che aveva quasi risparmiato la nostra città, dicevo che in fondo avevamo solo lavorato, come sempre, anche se in condizioni più difficili e con molta più paura. Oggi, dopo una seconda ondata che ci ha messi in ginocchio, non potrei mai dire lo stesso. Chi più ha pagato in questa pandemia sono i pazienti e le loro famiglie, a loro va il mio pensiero e il mio sostegno più grande, ma ho la fortuna di non poter parlare in loro vece. L’unica versione della storia che ho da raccontare, inutile che sia, è la mia.
Le cose sono cambiate tanto e tante volte che sembra sia passato un secolo: dalla prima trasformazione del nostro reparto in Pneumologia COVID, lo scorso marzo, di cui ricordiamo bene la paura, lo smarrimento, la confusione. A peggiorare il tutto, il terrore all’idea di essere fonte di contagio per i nostri cari, che ci ha portato ad allontanarci da loro. Solitudine e paura che si amplificavano al contatto con quella, drammatica e inevitabile, dei pazienti ricoverati. Poi a maggio la speranza, il ritorno ai nostri pazienti di sempre, le tute negli scatoloni, mascherine, guanti e occhiali protettivi sempre al loro posto, ma ci si poteva accontentare.
A ottobre il tracollo: casi in aumento ogni giorno, la riconversione del nostro reparto e presto di quasi tutto l’Ospedale. Turni e posti letto raddoppiati, il continuo ricambio di pazienti perché per uno in fase di guarigione ce n’era già un altro in coda ad attendere il ricovero. Il rumore costante dell’ossigeno a flussi altissimi, dei monitor, del tessuto plasticato delle tute protettive nei corridoi. I caschi, tanti, troppi caschi. Gli anestesisti che diventano presenza costante e fondamentale, le linee dell’ossigeno che iniziano a dare segni di cedimento, il senso di frustrazione nel non poter fare di più. Pazienti di tutte le età accomunati dalla paura, dal senso di isolamento, da quello sguardo ansioso e implorante quando sulle loro teste calava lo scomodo cilindro di plastica in cui riponevamo le speranze di miglioramento.
Abbiamo dato l’ultimo saluto a troppe persone, e non eravamo abituati, non eravamo pronti. È vero, la maggior parte di loro erano anziani, oltre gli 80 anni, come si sente dire spesso quasi a minimizzare il numero di decessi che cresce costantemente e che non sembra impressionare più. Ma il signor Giancarlo, con i suoi 82 anni, macinava chilometri in sella a una bici da corsa. Il signor Giovanni aveva passato gli 80, ma fino all’inizio del lock-down aiutava con i bambini nell’oratorio della sua parrocchia, e voleva solo tornare a casa per conoscere la nuova nipotina affidataria che stava per arrivare in famiglia. Il signor Mario viveva con sua moglie e non aveva mai avuto bisogno di aiuto…. Erano anziani, ma non è nostro compito stabilire quanto a lungo è degna di essere vissuta una vita, e molti di loro hanno lottato fino all’ultimo per ricordarcelo. Di tanti non ricordiamo il nome ma solo il cognome. Meritavano di andarsene accompagnati dai loro cari, e non dalla carezza di un infermiere o di un medico senza volto, tramite due paia di guanti, mentre il resto del lavoro chiama e non si può restare che per pochi minuti. Il maledetto virus gli ha tolto anche quel diritto. Ci porteremo dietro tutte queste morti, che ci hanno resi più fragili e insieme più cinici, ma il ricordo di molti volti forse sparirà dalle nostre menti con il tempo, e possiamo consolarci solo con la speranza di aver fatto del nostro meglio perché ciascuno avesse la miglior morte possibile, la minor solitudine possibile.
Per quanto mi riguarda però, la cosa peggiore era un’altra: ogni giorno, dopo il giro visite, ci aspettavano i colloqui con i parenti, al telefono. Le buone notizie portavano a chiamate leggere, allegre: la riduzione della terapia con ossigeno, il miglioramento degli esami, il trasferimento in riabilitazione… notizie banali, un tempo normali, sono diventate piccoli momenti di gioia e speranza, voci sollevate e ringraziamenti. Ma niente pesava di più sul mio stomaco delle chiamate ai parenti di pazienti critici: dover dire a una moglie, a un figlio, a un genitore, che le cose stavano andando male. Che poteva esserci bisogno di terapie invasive, in terapia intensiva, che non garantivano comunque la sopravvivenza. O peggio, che non c’era spazio per fare di più. In equilibrio sopra un filo, tra la voglia di lasciare un po’ di speranza e la necessità di preparare alle notizie peggiori, tra un fastidioso realismo e la tentazione di tranquillizzare e dire che sarebbe andato tutto bene. Un solo passo falso, una parola leggera detta a fin di bene, potevano portare a conclusioni errate e a una sofferenza ancora più grande. E tutto questo tramite un mezzo freddo e impersonale come la cornetta, senza che nessuna delle due parti conoscesse l’altra, senza poter stringere una mano, interpretare uno sguardo, offrire un po’ di conforto. Ancora una volta, solitudine.
Ci sono stati anche tanti momenti di gioia: l’uscita dei pazienti verso casa, la riabilitazione o i reparti di minor intensità. Le pizze offerte dai ristoratori che ci hanno sfamato per i primi mesi. Quelle giornate in cui nessuno era peggiorato, si riusciva a finire in orario e le cose sembravano un po’ meglio del giorno precedente. I colleghi che impari a conoscere sempre di più, di cui impari a fidarti e con cui condividi le difficoltà di ogni giorno, il caffè, una risata inattesa al briefing del mattino. Piccole cose diventate più importanti in quei mesi in cui l’unico contatto umano era all’interno dell’Ospedale.
Per il “mondo fuori” noi operatori sanitari siamo stati tante cose: eroi prima, poi untori, uccellacci del malaugurio, qualcuno addirittura ci ha chiamati bugiardi, insinuando che nulla di ciò che si sentiva al telegiornale fosse vero perché “mia madre lavora in ospedale e non ha mai visto niente del genere”. Non ho mai condiviso la logica dell’eroe: è il nostro lavoro, la sfortuna ha voluto che ci trovassimo a viverlo in un modo più estremo del previsto. Lo abbiamo fatto, come tutti in questo periodo, e ne abbiamo sofferto, come tutti. Però vi prego, non sminuite il nostro mestiere al grido di “ve lo siete scelto, ora non lamentatevi”: avevamo scelto di adottare un barboncino, al massimo un labrador, ci siamo ritrovati con un enorme San Bernardo con disturbi del comportamento e incontinenza. Non biasimateci se abbiamo fatto fatica, scusate se ve l’abbiamo fatto pesare. E se non credete a ciò che vi raccontiamo da mesi, beh, non credo ci si possa fare nulla.
Siamo consapevoli del nostro ruolo di ponte fra i malati e il mondo esterno, e questa è stata forse la novità più grande e il compito più difficile. Ci abbiamo provato, qualche volta ci siamo anche riusciti.
La mia strada ora si divide da quella dei colleghi, che continuano (speriamo ancora per poco) a combattere contro il virus maledetto, con i pazienti e le loro famiglie. Spero di aver dato voce anche alla loro esperienza, se così non fosse so che sapranno perdonarmi.
La lotta, per tutti in modi diversi, continua.”
Dott.ssa Letizia Traversi
Medico Pneumologia Ospedale di Varese
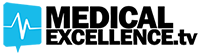











Aggiungi un commento